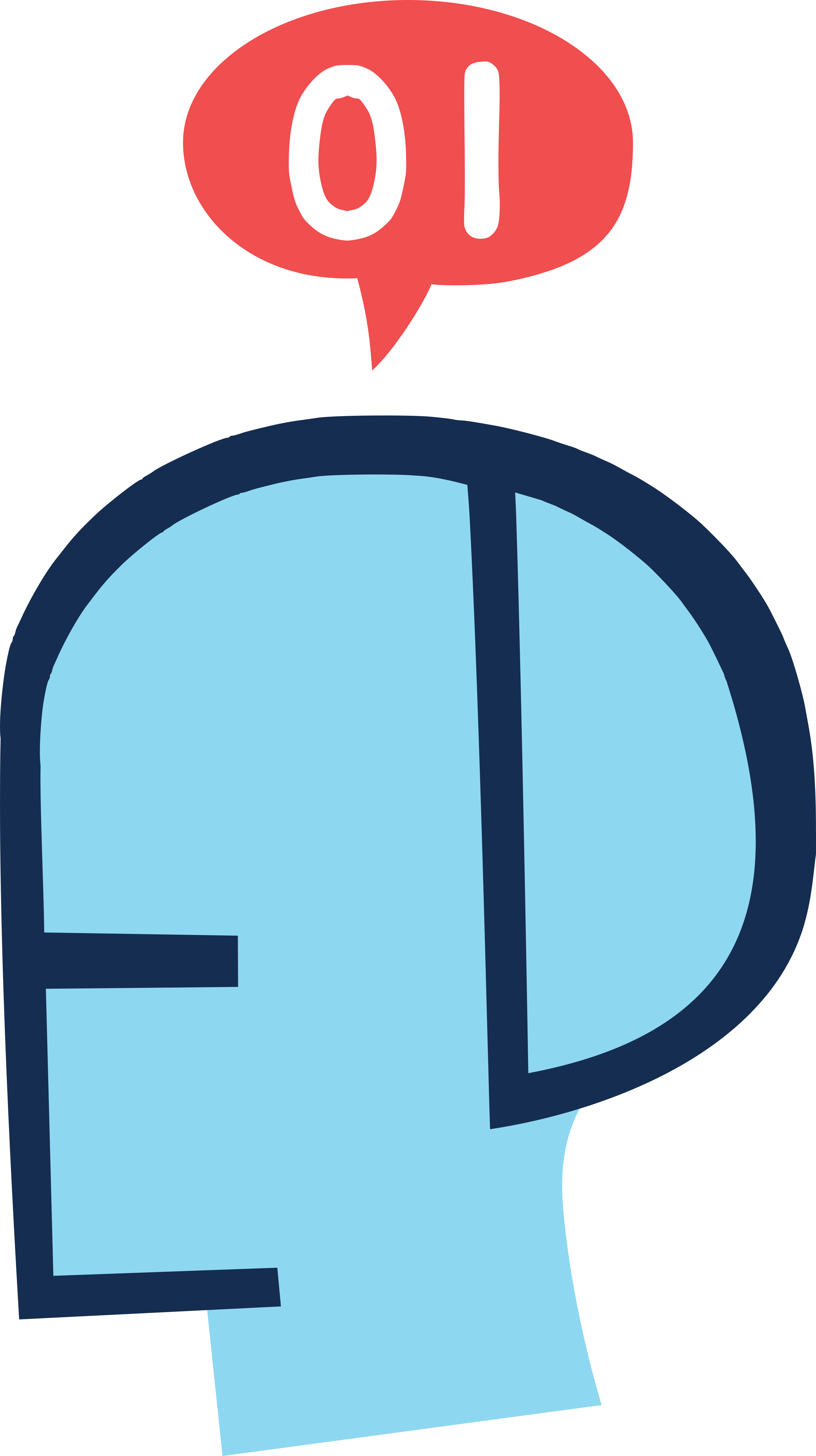Secondo uno studio di Corporate Europe Organisation, i soldi spesi sono in aumento rispetto agli anni passati: dai 97 milioni del 2021 si arriva ai 113 milioni del 2023.
40 di questi milioni appartengono, solo loro, ai colossi digitali, dove in cima alla classifica troviamo Meta con 8 milioni, seguita da Apple, Google, Microsoft, Amazon e Qualcomm. Il resto della spesa proviene invece da aziende più piccole, che spendono in media meno di 200 mila euro annui.
https://corporateeurope.org/en/2023/09/lobbying-power-amazon-google-and-co-continues-grow