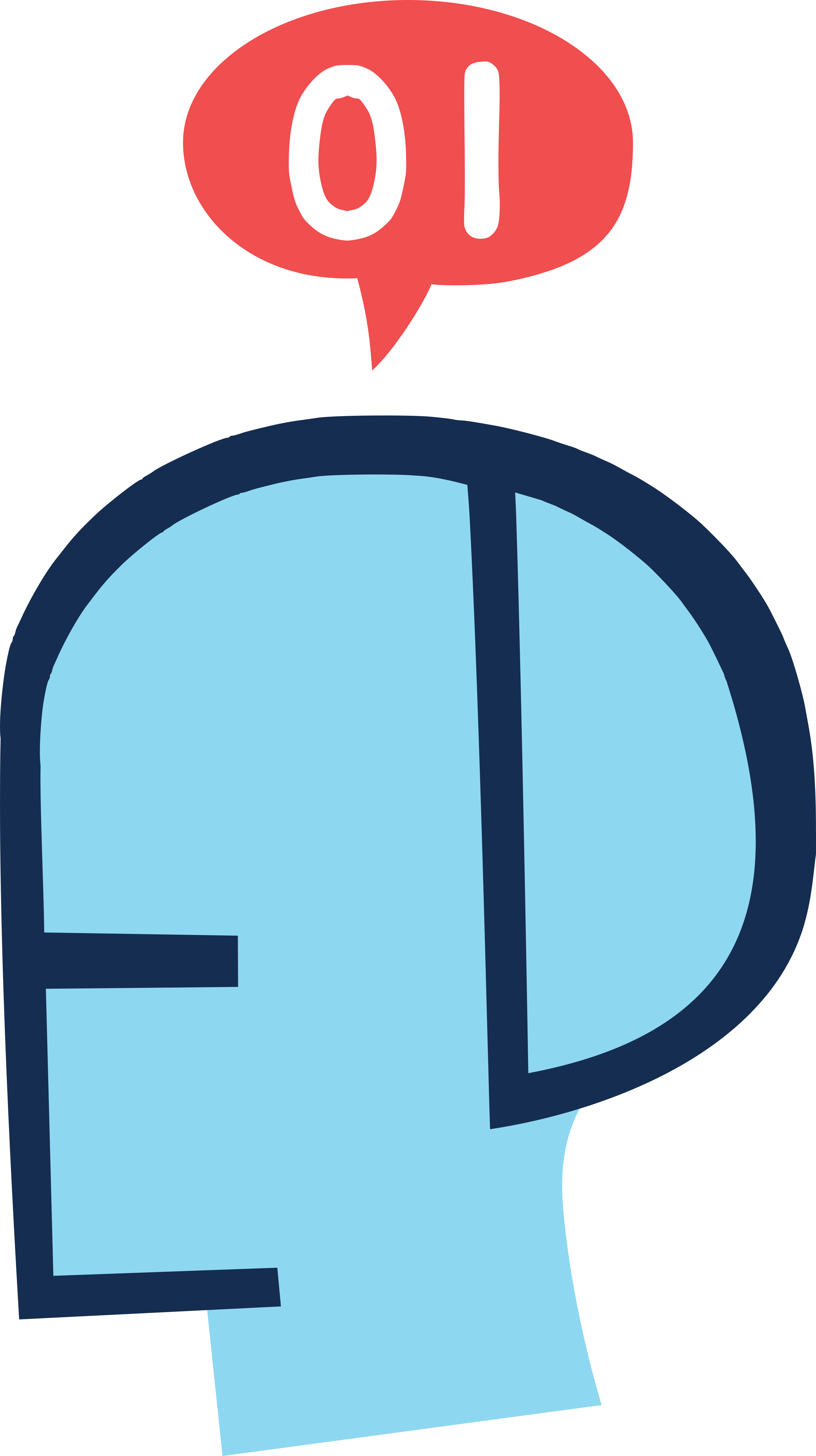Molka, il termine sud coreano per dire “telecamera spia”, è il nome con cui nel paese sono conosciuti dei crimini molto diffusi che consistono nell’installare telecamere illegali per ottenere filmati privati di giovani donne, spesso anche minorenni. Questo fenomeno è un tema centrale per il movimento femminista del #MeToo del Paese, da cui sono nati alcuni gruppi che si battono per un inasprimento delle pene contro i filmati illegali.
Nonostante la Corea del Sud sia molto avanzata tecnologicamente e arrivi in città come Seul ad avere un rapporto di una telecamera ogni 132 abitanti, la forte sorveglianza non è affatto sufficiente a contrastare il fenomeno del molka. Spesso, infatti, tra le forze dell’ordine sono diffusi sessismo e pregiudizi, che portano a dubitare delle vittime e a dare loro la colpa per essere state filmate contro la loro volontà. Foto e filmati finiscono poi su comunità e chat online, come nel famoso scandalo de “L’Ennesimo Caso” in cui è stato venduto materiale di 103 vittime, di cui 26 minorenni, ad oltre 60.000 utenti tramite Telegram.
A seguito di questo scandalo, in Corea del Sud è stata approvata una legge informalmente conosciuta come “Legge dell’Ennesimo Caso”, in cui si costringe le grandi compagnie social e siti web con più di 100.000 utenti giornalieri ad implementare dei filtri sui contenuti. Questo ha portato il popolo coreano a ricevere notifiche nelle chat pubbliche, in cui le persone venivano avvisate che le loro foto e video sarebbero state sottoposte a revisione per verificarne la legalità – una cosa che non hanno per niente gradito, portando l’opinione pubblica a schierarsi fortemente a sfavore della legge e a dimenticarsi dell’Ennesimo Caso.
L’associazione senza scopo di lucro Open Net Korea sostiene infine che il filtro limiti la libertà di espressione del pubblico e il diritto alla conoscenza: che questa legge non aiuti a prevenire o contrastare i crimini, e che le persone si limiteranno semplicemente a trovare nuovi modi per continuare a fare quello che stavano facendo.
https://www.codastory.com/authoritarian-tech/molka-digital-sex-crimes-south-korea/