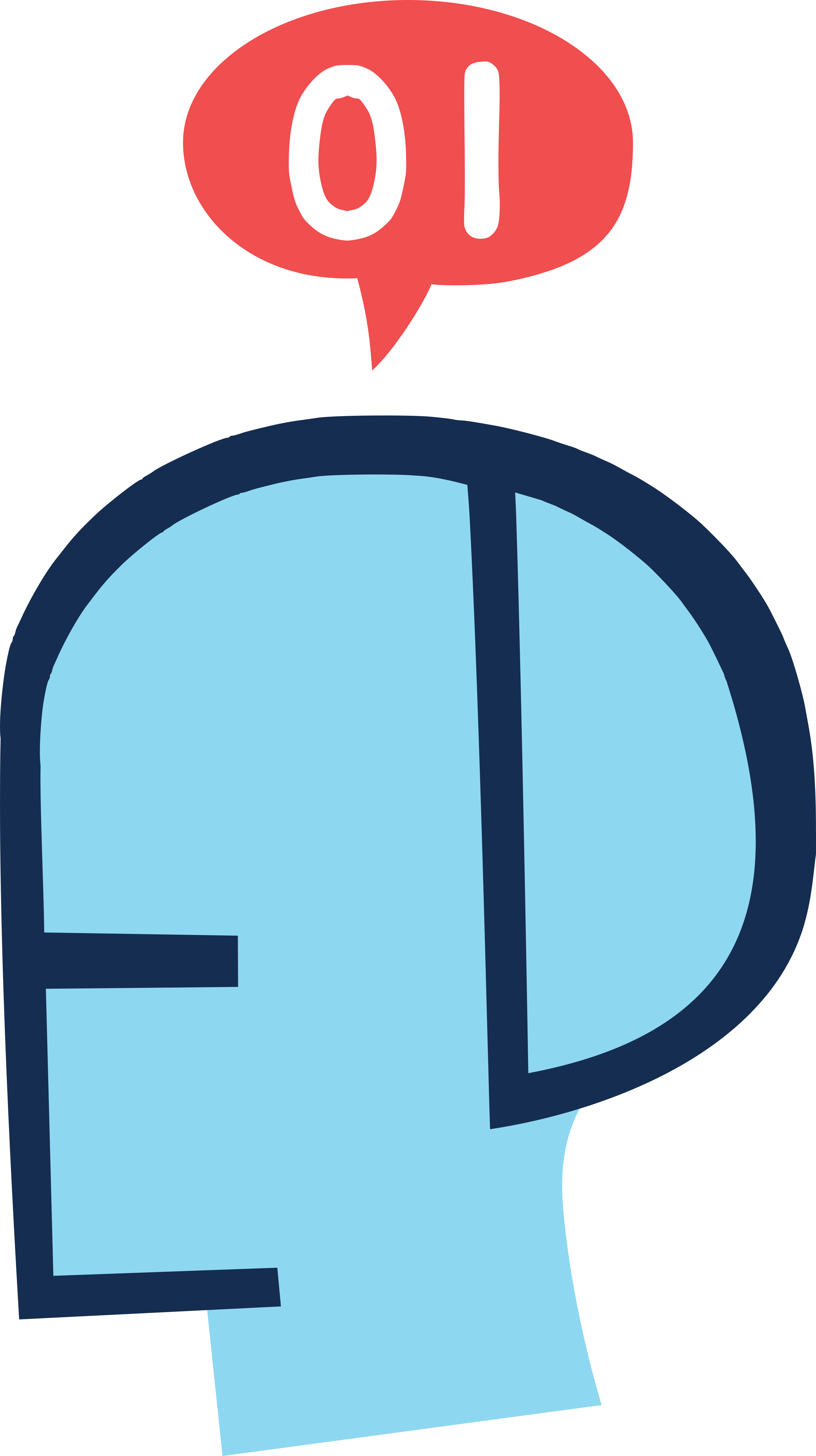Stando a una fonte che ha richiesto l’anonimato, la prossima settimana TikTok ha pianificato tre giornate per far scendere lɜ influencer per le strade di Washington (a spese del social), con tanto di conferenza stampa finale a Capitol Hill.
“Lɜ legislatorɜ dovrebbero ascoltare in prima persona coloro che verranno impattatɜ direttamente da queste scelte politiche”, ha commentato il portavoce di TikTok, un social che da anni cura le sue pubbliche relazioni e fa lobbismo per evitare simili problematiche
https://www.politico.com/news/2023/03/17/tiktok-dc-government-influencers-00087653