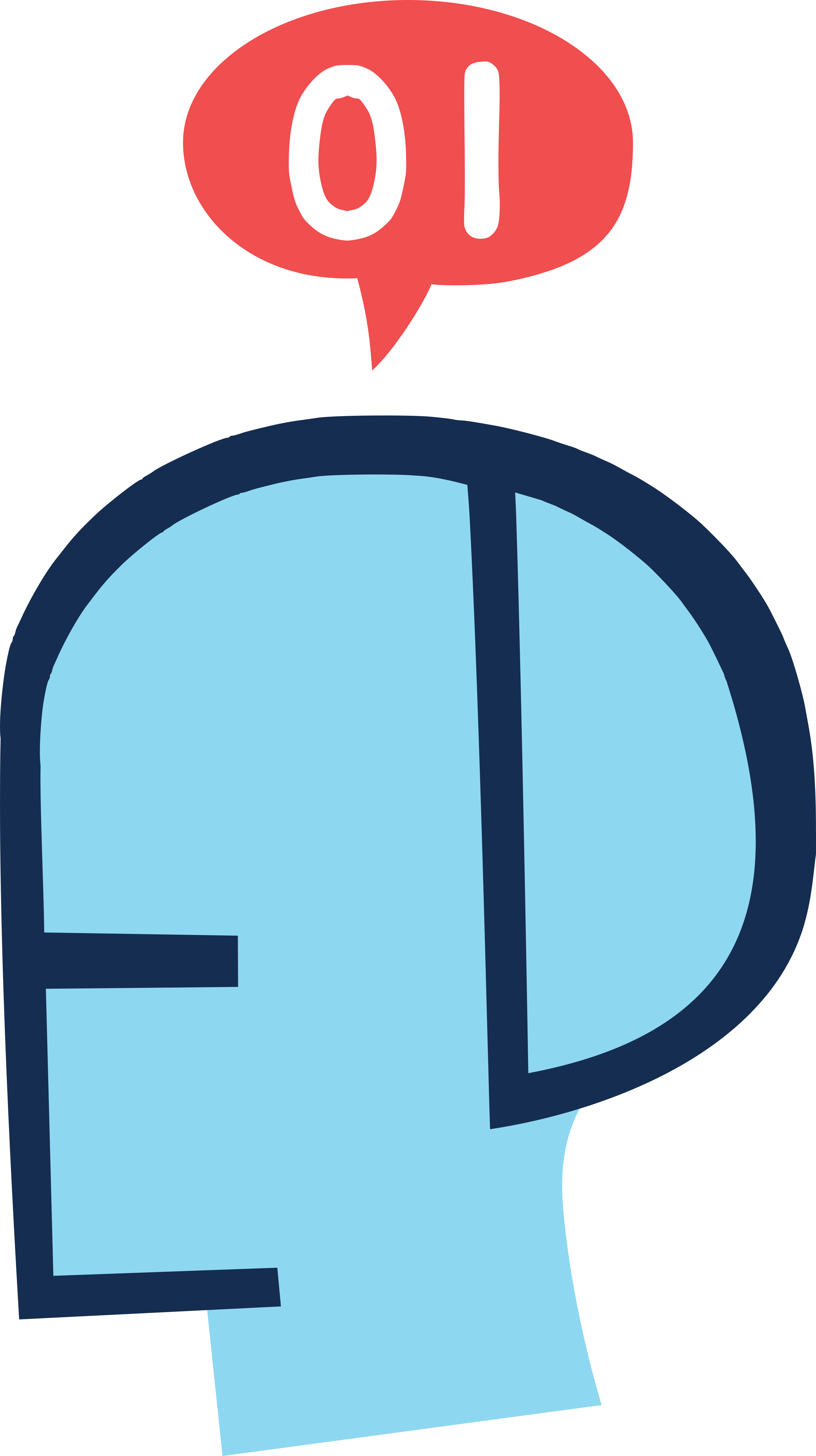Se dovessimo trovare una battaglia di spicco che in quanto Etica Digitale abbiamo portato avanti nell’ultimo anno e mezzo, questa sarebbe il documentare la situazione scolastica italiana in rapporto alla pandemia – ad oggi purtroppo invariata. Man mano che investivamo il nostro tempo tra presidi, sentenze giuridiche e un continuo adattarci al mondo che ci circonda, quest’ultimo, come normale che sia, ha dato vita a nuovi fenomeni: teorie del complotto esplose in rete (prima fra tutte QAnon), censure sempre più presenti, vite in remoto (non chiamatele smart quando tutto il mondo parla di remote working), aziende tecnologiche conseguentemente più ricche con divari economici sempre più grandi. Insomma, le narrazioni cambiano ed è facile perdersi nella confusione – soprattutto quando i mezzi d’informazione soffocano le persone in quella che è stata definita infodemia.
Se l’andare piano è uno dei valori fondanti di Etica Digitale (non vedrete mai più di 2 post al giorno sul canale Telegram, né verrete tempestati di articoli sul sito), bisogna però anche capire dove andare. Perché un gruppo volontario di ragazzi e ragazze non è una redazione con uno stipendio, ovvero gli argomenti che possiamo trattare – e trattarli bene – tanto quanto le energie che possiamo impiegare, sono molto più limitate rispetto a chi, invece, lo fa per lavoro. Si pensi per esempio a quando uscì il Barometro dell’Odio 2021 di Amnesty International, di cui parlammo sul canale Telegram: dato che prima di pubblicare qualcosa la visioniamo integralmente per valutarla, pubblicare quel rapporto è equivalso a leggere circa 60 pagine, diluite in qualche giorno di tempo. Tempo che, di conseguenza, non è stato possibile impiegare per fare dell’altro.
Riducendo il tutto a una domanda ci siamo chiesti: su quali pochi aspetti concentrarsi, considerando il tempo limitato che si ha?
Con l’estate quasi a simboleggiare l’inizio di una nuova fase, vi presentiamo di seguito le nostre scelte.
1. Il confronto per crescere (forum)
Scegliere su cosa discutere serve a poco se poi manca uno spazio per confrontarsi. Un gruppo Telegram è ottimo per comunicare rapidamente, tuttavia non è il massimo quando si vuole andare in profondità. I messaggi si perdono facilmente, scriverne di troppo lunghi risulta scomodo e può addirittura essere considerato maleducato (tipo i copia-incolla massivi). Insomma, Telegram non è e non potrà (giustamente) mai essere uno strumento universale per tutto. È per questo motivo che, dopo mesi di prove e ricerche – e grazie anche all’aiuto della nostra comunità – Etica Digitale ha optato per aprire un forum, la soluzione da noi ritenuta più ordinata quando si tratta di discussioni lente e approfondite. Ispirandoci a modelli come Inforge, abbiamo usato un software libero (Flarum) per creare una piattaforma che rispondesse alle necessità estetiche e funzionali dei giorni d’oggi, nella speranza di creare un ambiente pratico e intuitivo per chiunque volesse prenderne parte. Lo trovate da oggi linkato nella parte alta del sito (ma anche qui => forum.eticadigitale.org) e vi invitiamo caldamente a farci un salto.
2. La privacy è un diritto di tutti. e tutti devono essere in grado di comprendere facilmente perché è fondamentale (un sito a parte per PrivaSì).
Quando si parla di comodità, un sito sconosciuto ai più come GitLab non è certo il primo che viene in mente per rapportarsi col pubblico. Per questo motivo, da oggi è disponibile un sito a sé stante, semplice e intuitivo, per leggere la prima sezione della nostra guida sulla privacy. “Prima sezione” perché, al contrario di quello che succede dietro le quinte, vogliamo offrire un’esperienza pulita a chi decide di sfogliarla, garantendo una qualità maggiore rispetto a quelle in corso di sviluppo. Per l’occasione abbiamo riscritto un capitolo per intero e rivisto la narrazione in molti altri, nel tentativo di analizzare sotto una nuova luce quella riservatezza (perché alla fine questo vuol dire privacy) che le grandi compagnie hanno snaturato per l’ebrezza di più soldi e più potere. Infine, ancora più importante, la stesura è ripartita spedita, e invitiamo chiunque voglia aiutarci, a collaborare con noi dietro le famose quinte.
La guida => privasi.eticadigitale.org
3. Giocare ai videogiochi non deve pesare sulle vite di chi non ha voce (sviluppo di un gioco libero)
A ripresa del nostro anno di contributi su Minetest e alle denunce mosse contro case come Riot Games, Blizzard e Supercell, questa volta abbiamo voluto puntare più in alto: Etica Digitale vuole fronteggiare in prima linea questi colossi che ignorano i diritti umani, sviluppando un gioco online – ovviamente software libero – per non obbligare più i giocatori e le giocatrici a scendere a patti con certi mostri. Synthetic Stars (questo il nome) è un hack’n’slash che riprende l’adrenalina dell’ormai defunto S4 League, con l’intento di creare qualcosa che non sia semplicemente open source (già esistono svariati titoli come Red Eclipse 2 e Xonotic), ma che sia al livello dei titoli oggi in voga.
Il progetto, sviluppato su Godot, è ancora in fase primordiale, e vi faremo sapere di più una volta che avremo qualcosa di solido.
4. Abbattere i giganti
A ripresa del punto precedente, e a ripresa delle ingiustizie scolastiche di cui abbiamo trattato da un anno e mezzo a questa parte, la nostra attività divulgativa qui sul sito punterà a gettare una luce critica verso quei giganti tecnologici che sono soliti riempire le nostre vite. Se si vogliono compiere scelte consapevoli, infatti, è necessario prima di tutto essere informati (non per niente il nostro piccolo slogan è “libera la tua scelta”). E questo è molto difficile farlo quando dall’altra parte vengono spesi milioni e milioni in marketing per sanificare l’immagine delle singole aziende. Prendendo ispirazione da quelle testate internazionali che siamo soliti consultare (The Intercept, Rest of World e tante altre), ci muoveremo dunque con l’intento di creare un’informazione che sia usufruibile senza barriere linguistiche, nella speranza di rendere certi dibattiti più centrali nell’opinione pubblica. Con pochi articoli, ma – ci auguriamo – buoni.
Ringraziamo infine tutte e tutti coloro che hanno preso parte ai nostri circoli di lettura, che riprenderanno a ottobre dopo una pausa estiva (a settembre avviseremo su Telegram e Mastodon riguardo il prossimo tema). Se, inoltre, volete supportare quello che facciamo e permetterci di dedicare più tempo al tutto, ricordiamo che abbiamo una pagina LiberaPay per le donazioni, e che da un mese a questa parte è possibile donare sia tramite PayPal che – se volete mantenere l’anonimato – tramite prepagata (ma anche via bonifico) grazie alla tecnologia libera Stripe integrata nel sito.
A prescindere da donazioni e contributi, grazie per essere parte di questa piccola realtà di volontariato e per credere in quello che facciamo.